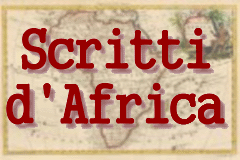Paul Kaplan, Shaul Bassi
Paul Kaplan, Shaul Bassi
Venezia africana
Arte, cultura, persone
Edizioni Wetlands, 2024
Il primo autore, professore di storia dell'arte in una università americana dello stato di New York e il secondo, professore di letteratura inglese alla Ca' Foscari di Venezia, hanno dato vita ad un curioso ed intrigante libro di itinerari veneziani per scoprire la presenza antica e attuale dell'Africa a Venezia, nella laguna veneta e nelle città entroterra della Serenissima. Si sono avvalsi della prefazione della scrittrice italo somala Igiaba Scego e della postfazione della scrittrice etiope Maaza Mengiste.
Ma il testo è anche un collage di articoli, poesie, approfondimenti di diversi autori europei, africani (c'è anche un bel testo poetico di Ngugi wa Thiong'o) e americani che completano lo sguardo di Kaplan e Bassi, anche con numerosi riferimenti alla presenza africana odierna a Venezia e a Mestre.
Si tratta di 10 itinerari, in gran parte modellati sui sestieri veneziani che cercano di descrivere minuziosamente la presenza africana nell'arte, nella cultura e nel tessuto urbano della città, entrando anche in piccoli musei come quello dei profumi o in case private in cui normalmente i visitatori non sono ammessi. Itinerari che non possono fare a meno di far riflettere sulle rotte commerciali delle merci e delle persone schiavizzate, la cui presenza è ampiamente testimoniata dalle tele di vari grandi artisti come Gentile Bellini, Vittore Carpaccio, Paolo Veronese, Giambattista Tiepolo, Pietro Longhi, Francesco Guardi, solo per citare i più noti.
La presenza di schiavi africani è attestata soprattutto a Venezia, tuttavia si trovano presenze nere anche a Napoli, Sicilia, Firenze e in minore misura nel Nord Italia.
Le immagini pittoriche e scultoree veneziane sono soprattutto maschili, non perché non vi fossero schiave nere, ma perché i lavori più rappresentativi, barcaioli e gondolieri, paggi e camerieri erano più consoni alla rappresentazione della grandiosità dei rituali sociali e mondani, delle folle inneggianti al potere veneziano nei momenti soprattutto del massimo splendore dal '400 al '600, fino all'avanzata dei Turchi e allo sviluppo delle rotte atlantiche. Esibire schiavi ben vestiti per la classe dirigente veneziana era un modo per testimoniare il proprio lusso e potere.
Spesso si fa fatica a capire cosa i veneziani, a partire dal XII secolo, intendessero per 'africani', dal momento che a volte vediamo rappresentate persone scure di pelle ma in abiti turchi, con i caratteristici turbanti tondeggianti o in caffettani tipici del nord Africa arabo. Questo perché i legami commerciali diretti di Venezia erano rivolti soprattutto all'Africa mediterranea, al Medioriente e all'amico-nemico di sempre: l'impero turco. Nell'uso veneziano spesso tutti i neri venivano apostrofati come 'etiopi', data la conoscenza di questa terra, o ‘mori’ che poteva pero' semplicemente significare musulmano, anche della Spagna islamica. In un primo tempo gli schiavi dovettero essere quasi tutti slavi, ma dal IX sec. (anno del trafugamento del corpo dell'evangelista Marco, all'origine della grandiosa chiesa omonima nel centro politico-religioso della città) e soprattutto dall' XI cominciò a crescere la presenza di schiavi anche neri, pur se non si conoscono, in Venezia, luoghi deputati ad un ipotetico mercato degli schiavi. Il flusso durò fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Ma nell'immaginario internazionale si lega Venezia solo a Marco Polo e all'Oriente.
Se fino al '500 le immagini artistiche, nelle chiese, nelle case, negli angoli delle strade e dei ponti, sulla facciate dei palazzi non sembrano indicare un particolare disprezzo verso gli africani, dal '600 in poi si nota una sorta di suprematismo bianco ante litteram, come nella rappresentazione dei 4 schiavi che sorreggono per l'eternità la tomba del doge Giovanni Pesaro, colti nella sofferenza dello sforzo; o nella ridicolizzazione che nasce dall'uso di personaggi africani portatori di lampade o basi di consolle e tavolini, rappresentati con il classico collare da schiavo o in catene, inventati dall'ebanista Brustolon nel '600. I gioielli con i cosiddetti 'moretti di Venezia' sono un’ulteriore testimonianza dell'uso dei corpi dei neri: preziosissimi esempi di arte orafa, celebri in tutta Europa, oggi decaduti, per i comuni turisti, a oggetti di scarso valore, orecchini e collanine, forse...cinesi.
Più misteriosa la presenza di una testa di moro come stemma araldico di un armigero nel Martirio di San Giorgio a Padova nell'Oratorio di S. Giorgio, forse ricordo ed emblema dei saraceni combattuti nelle crociate (e sembra non essere l'unica testimonianza araldica nobiliare). Si evince da mosaici e pitture che i corpi dei neri fossero utilizzati per un doppio motivo: sono spesso neri (la nerezza della malvagità e del peccato) i torturatori di Cristo o dei martiri, ma nello stesso tempo ci sono ritratti di neri nelle folle intorno a Cristo o ai santi per indicare l'universalità del cristianesimo. Interessante, dal medioevo in poi, la comparsa del 'Re magio' africano, apparsa in Germania la prima volta, ma molto sfruttata dagli artisti veneziani.
Per concludere con le immagini artistiche del passato, l'elegantissimo e colorato bel giovane gondoliere africano del Miracolo della reliquia della Croce al ponte di Rialto del Carpaccio, contrapposto al corpo nudo anonimamente nero, con uno straccio incolore intorno al bacino, con un viso appena abbozzato, in atto di lanciarsi in laguna per recuperare una reliquia caduta, ritratto da Gentile Bellini, simboleggiano l'ambiguità veneziana che nasconde la dura realtà della schiavitù con l'esibizione del lusso dei servi, emblema del loro potere. Se non abbondano le immagini delle donne nere, troviamo invece numerosi bambini in veste di paggetti, insieme a giocolieri e nani buffoni. Come si vede, la sequenza indicata indica soggetti marginali della società.
Negli itinerari esce fuori la storia delle rotte del caffè (spesso gestito da membri della numerosa comunità ebraica) che non sono per Venezia intercontinentali, ma legati soprattutto ad Alessandria d'Egitto; le rotte dei profumi nordafricani e somali, la storia delle perle di vetro di Venezia e Murano, intreccio di commercio, sfruttamento e violenza coloniale. Le perle veneziane furono un'importante forma di monete in varie parti dell'Africa fino al XIX secolo.
Nel testo c'è spazio anche per l'aneddotica, la curiosità botanica, i giudizi di artisti del passato che hanno visitato Venezia e per la parola ghetto che da Venezia si è diffusa nel mondo per indicare luoghi di reclusione ed emarginazione sociale.
Particolare rilevanza assume la leggenda di Otello, il moro per eccellenza quando si pensa a Venezia. Traversando la città viene mostrata ai turisti, senza alcun timore di ridicolo, la casa di Otello e la casa natale di Desdemona, come se questi fossero stati personaggi realmente esistenti. Sappiamo che Shakespeare deve aver preso la storia da un testo italiano cinquecentesco oppure che sia venuto a conoscenza della vita reale e testimoniata di Zuan Bianco, condottiero moro, realmente esistito, morto in battaglia per la Repubblica, la cui famiglia viene ricompensata con una pensione a vita e una casa stabile. Sicuramente in Venezia deve esserci stata una certa mobilità sociale che ha permesso ad alcuni ex-schiavi liberati di ascendere socialmente, proprio come Otello che arriva ad uccidere per le incertezze psicologiche in cui si trova: è accettato fino ad un certo punto dalla società, probabilmente non è bastato essere un famoso condottiero per accedere ad una donna bianca di cui non capisce forse i desideri. Ma quando un nero diventa veramente 'uguale'?
Questo ci porta alla parte attuale della presenza dei migranti, che abitano a Mestre ma lavorano a Venezia (città proibita per le loro tasche) e anche alla presenza di artisti africani, testimoniata da Akka Project e dall'ultima Biennale del 2024, in cui gli africani hanno avuto maggiore spazio che in passato. L' Akka Project rappresenta uno spazio dedicato ad artisti africani emergenti, basato su programmi di residenza, invitati a confrontarsi con l'arte del passato, ma anche con temi che riguardano la Venezia dell'oggi. Un esempio è rappresentato da Il mercante di Venezia (titolo esplicitamente shakespeariano) di Kiluanji Kia Henda, che immagina un attuale migrante africano venditore ambulante, sontuosamente vestito di sete colorate, come nelle tele veneziane, con nelle mani le famose borse di lusso contraffatte.. Uno spazio particolare è dedicato all'itinerario ottavo che riguarda gli ambienti espositivi della Biennale, con particolare riferimento al progressivo guadagno dei luoghi da parte dei padiglioni nazionali africani, dove i più longevi sono quelli dell'Egitto, del Ghana e del Sudafrica. Ripercorrendone la storia vengono evidenziate le manchevolezze nel voler porre un 'cappello' europeo agli artisti africani, decidendo cosa sia africano e cosa non lo è, ma anche le difficoltà nel comprendere le specificità non solo di ciascun artista, ma anche di ciascun paese, mettendo un marchio di lettura riduttiva alla creatività diversificata di un continente intero.
In conclusione, un testo affascinante che fa venir voglia di visitare Venezia con un altro occhio, postcoloniale e multiculturale, rinverdendo e modificando ad un tempo l'immagine della Serenissima che è sempre stata un incrocio di oriente e occidente, mondo slavo e mondo mediterraneo, di cristianesimo, ortodossia e islam.