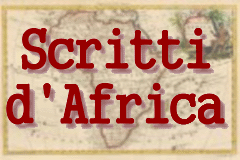Africana.
Africana.
Viaggio nella storia letteraria del Continente
A cura di Chiara Piaggio e Igiaba Scego
Feltrinelli, 2024
In meno di cento anni la fase moderna della “letteratura africana” (1) ha conosciuto una crescita esponenziale. C'è stato un tempo in cui per essere considerato parte della “letteratura africana” dovevi essere pubblicato nella collana degli scrittori africani. Adesso tutte le migliori case editrici ritengono di rigore avere uno scrittore africano tra i loro libri. È la letteratura più in espansione al mondo. C'è chi arriva a dire che il futuro è la “letteratura africana”.
Ciò non ci sorprende visto che anche come Associazione Scritti d’Africa ormai da decenni constatiamo l’incalcolabile ricchezza delle realtà africane e di come essa esploderà nella letteratura dei tempi a venire. Non solo le storie, ma anche la natura della sensibilità africana, conservatrice e innovativa allo stesso tempo. Sono poche le tradizioni che hanno contemporaneamente, in egual misura, l’inclinazione a rispettare – anzi venerare – la tradizione e l’impulso evolutivo a fare il nuovo, a creare nuove danze, forme, sogni, profonde riflessioni, grandi capacità tecniche. A questo mix si aggiungono le enormi pressioni sulla vita africana, derivanti dalla povertà, dalla politica, dalla sofferenza, dalla tradizione, dalla modernità, insieme alle incommensurabili bellezze della realtà africana: la fertilità delle storie, la capacità di gioia, l’inimmaginabile resilienza, l’incredibile giocosità, l'umorismo sfrenato, l'immensa capacità di perdono, l'incredibile ospitalità…
Africana. Viaggio nella storia letteraria del Continente, antologia di racconti o brani estratti da romanzi di più autori e autrici di diverse generazioni , ottimamente curato da Igiaba Scego e Chiara Piaggio ne è la dimostrazione: è avvincente, ricca di drammi, humour e sorprese questa raccolta approntata da una scrittrice e da una antropologa. Ricordando la scrittura di storie dall’epoca coloniale a oggi, il volume ha un precedente: “Africana. Raccontare il Continente al di là degli stereotipi”, antologia di storie e riflessioni pubblicata nel 2021. Se la raccolta di tre anni fa era molto efficace, letterariamente parlando, questa è più omogenea e lineare, ha una qualità più alta perché improntata quasi esclusivamente su scelte narrative, non saggistiche, e ha utilissime schede su ogni scrittore e scrittrice.
I cinque capitoli, per fasi cronologiche, dal ‘900 sotto la colonizzazione, fino ad arrivare ai nostri anni, chiariscono bene il taglio del libro: “Uno | Sotto il tacco coloniale”; “Due | Le speranze tradite delle indipendenze”; “Tre | Rinnovamenti e turbolenze nel Novecento che tramonta”; “Quattro | Nuove energie, nuovo millennio”; “Cinque | Il futuro è già presente”.
Il repertorio selezionato conferma quanto siano stimolanti i contenuti. Tra i nomi più conosciuti potremmo citare lo scrittore e regista senegalese Ousmane Sembène, la dolente, magistrale e toccante Bessie Head, nata da una coppia mista nel Sud Africa dell’Apartheid e riparata in Botswana; il keniota da anni evocato ad ogni Nobel, Ngugi wa Thiong’o, cui si affiancano autentiche sorprese: come il giovane ed esordiente namibiano Ndawedwa Denga Hanghuwo per le nuove generazioni.
I contenuti selezionati per ognuno dei cinque capitoli riflettono a pennello l’andamento e lo sviluppo della letteratura africana sin dal primo impatto con la cultura dei colonizzatori. Nella presentazione di ognuna, le curatrici sembrano dirci che, quando si ha a che fare con la “letteratura africana”, bisogna tener presente che essa è radicata nella cultura orale dei popoli dell’Africa, anche se l’influenza del colonialismo, dai temi allo stile di scrittura, ha subito grandi metamorfosi nel corso degli anni, estraniandosi dalla coscienza africana. Molti scrittori, anche quelli del periodo coloniale, si sono appropriati di modelli europei e li hanno fatti propri con sapore africano.
La letteratura africana degli anni cinquanta, per fare un esempio, era caratterizzata dalla sua attenzione agli effetti dirompenti del colonialismo europeo sulla società africana tradizionale. Quando le nazioni africane iniziarono ad emergere da secoli di dominio coloniale, gli scrittori rifletterono sull’imposizione dei valori occidentali ed esaminarono i nuovi conflitti che accompagnavano l’indipendenza. L'epoca fu degna di nota anche per la proliferazione di opere scritte da neri africani in inglese, sebbene in alcuni casi si trattasse di un inglese che era stato significativamente rimodellato fondendosi con le lingue indigene.
Il libro mi è stato di grande stimolo per formulare un elenco di domande sul passato, presente e futuro della letteratura africana, del suo enorme contributo locale, sociale, politico, pedagogico… domande come: “Quale è l’“africanità” della letteratura africana e il rapporto che essa rappresenta con la letteratura tradizionale? In che modo essa riflette l’antropologia, la sociologia, l’economia, la storia africana; considerando gli scritti di matrice africana prima dell’epoca coloniale, in che modo il colonialismo Occidentale ha influenzato la cultura e la letteratura in Africa? Come si presentava la letteratura africana nel suo complesso durante il periodo coloniale? Quali sono le caratteristiche della letteratura “africana”, e quali le difficoltà attuali? Che cosa si intende quando si parla della letteratura moderna “africana”? Il futuro, le prospettive della letteratura in Africa…e via dicendo.
La nuova scrittura africana nelle lingue europee (inglese e francese in particolare) crebbe a passi da gigante e nel suo percorso vide quattro africani vincere il Premio Nobel per la letteratura . Il “nuovo arrivato” ha fatto sorgere tra lettori e critici la domanda: 'Cos'è la letteratura africana? In cosa si differenzia dalle letterature già conosciute nel mondo? Alcuni la identificarono semplicemente come un'"appendice alle letterature britannica e francese" poiché gran parte della scrittura era in quelle due lingue. Non ci volle molto, però, per dimostrare che questa opinione era sbagliata.
Numerosi autori, nigeriani e kenioti in particolare, che scrivevano in inglese raggiunsero fama internazionale durante gli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Il primo fu Amos Tutuola, il cui classico racconto di ricerca, The Palm-Wine Drinkard, era intriso di tradizione orale di matrice Yoruba. Nel suo potente primo romanzo, Things Fall Apart, Chinua Achebe descrisse lo scontro di culture derivante dall'apparizione dei missionari europei in una comunità Ibo all'inizio del XX secolo. Il drammaturgo premio Nobel Wole Soyinka scrisse il dramma ammonitore A Dance of the Forests, rappresentato per la prima volta nel 1960, per le celebrazioni dell'indipendenza della Nigeria. Usando il suo caratteristico stile satirico, Soyinka suggerì che la nazione doveva ancora affrontare problemi difficili anche dopo la fine del dominio coloniale.
Anche i bianchi sudafricani hanno dato significativi contributi letterari affrontando la difficile situazione dei neri durante la tarda era coloniale. Alan Paton ha scritto liricamente sull'apartheid nei suoi romanzi Cry the Beloved Country (1948) e Too Late the Phalarope (1953). Così pure Nadine Gordimer, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1991, che iniziò a scrivere sull'ingiustizia dell'apartheid negli anni '50.
Per quanto riguarda la definizione di letteratura africana moderna , siamo ancora nella fase postcoloniale e, a mio avviso, ciò che alcuni considererebbero “moderna” è semplicemente un altro strato del continuo nesso postcoloniale. La vera letteratura africana moderna dovrebbe essere una letteratura africana liberata e libera di esprimere pienamente il suo ethos e il suo colore in piena “africanità”. Naturalmente ciò non può essere fatto quando la maggior parte dei romanzi, della prosa e della poesia degli africani sono ancora formulati e articolati nelle lingue coloniali.
Negli ultimi cinquanta, sessanta anni sono aumentati in modo esponenziale i dibattiti e impegni critici attorno alla scrittura africana moderna. (2) Inoltre, gli scrittori sono stati coinvolti nel processo iniziale di elaborazione di una tradizione critica, tra di loro o con la presenza dei critici, in dibattiti che vanno dalla questione degli standard critici al ruolo dello scrittore nella società. Morning Yet on Creation Day (1975) di Chinua Achebe, Myth, Literature, and the African World (1976) di Wole Soyinka e Decolonising the Mind (1986) di Ngugi wa Thiong'o sono alcuni dei contributi più importanti alla critica letteraria africana.
Uno dei primi dibattiti riguardava la definizione di letteratura africana. Gli scrittori e i critici che si riunirono in Uganda nel 1963 affrontarono la questione fondamentale di determinare chi fosse qualificato come scrittore africano e cosa fosse qualificato come scrittura africana. Il culmine del dibattito che ne seguì fu il famoso saggio di Obi Wali, "Il vicolo cieco della letteratura africana " (1963), in cui dichiarava che la letteratura scritta nelle lingue europee non si qualificava come “letteratura africana”. (3) Questo fu l'inizio del dibattito sulla lingua atavica in corso. Sebbene Achebe si sia opposto alla posizione di Wali, Ngugi l'ha abbracciata, trasformando l'appello per il ritorno alle lingue africane in una crociata critica che dura da più di tre decenni.
La letteratura “africana” contemporanea, al di là delle lunghe diatribe precedenti, riveste invece un’importanza significativa per una serie di motivi: fornisce una piattaforma per le voci, le esperienze e le prospettive degli scrittori e dei narratori africani che riflettono la complessità delle società, delle culture, delle storie, svolgendo un ruolo cruciale nel preservare e promuovere il patrimonio culturale, catturando miti, tradizioni orali e resoconti storici. Essa affronta eventi storici, lotte sociali e questioni politiche che hanno plasmato il continente. Attraverso romanzi, memorie e altre forme letterarie, gli scrittori africani forniscono preziose informazioni sull'era coloniale, sulle lotte postcoloniali, sui movimenti di indipendenza, sull'apartheid, sui diritti civili e su altri movimenti storici e sociali significativi.
In conclusione. C'è stato un tempo in cui la letteratura africana veniva relegata in una forma di ghettizzazione. Ora è un universo. Da sempre l'eccellenza dei suoi praticanti trasforma la percezione di un luogo, di una scuola, di una tradizione, di una nomenclatura. È una letteratura che ha alterato la geografia della letteratura mondiale. Ed è solo all'inizio. Il genio è stato liberato dalla bottiglia e non può più essere rimesso lì. Ed è un genio formidabile, pieno di secoli di storie e sogni da creare e condividere.
Oggi la letteratura africana sta conquistando il mondo. È germogliata dall'Africa, ma è cresciuta in tutti gli angoli del globo. È una letteratura delle terre natali, ma è anche una letteratura di sensibilità, di esilio, di migrazione, di viaggio, di partenza, di permanenza, di ritorno a casa. È una letteratura che non può più essere contenuta in un continente, né in una scuola, né in un nome, né in un'omogeneità. È una letteratura aperta al passato, presente e futuro.
1) Le letterature africane sono solitamente classificate e insegnate all’interno di un quadro continentale - nella categoria della “letteratura africana” - un termine geografico che implicitamente ignora la miriade di differenze regionali, nazionali, culturali ed economiche in un continente composto da cinquantaquattro paesi. In effetti, l’invenzione coloniale di un’“Africa” composita e singolare rimane tanto radicata nelle istituzioni accademiche quanto lo è nell’immaginario globale. Nella metà del secolo tramontato c’era in Occidente chi dubitava sull’esistenza della “letteratura africana” e “cultura africana”. I termini “africano” e “letteratura” sono piuttosto fuorvianti o quantomeno fraintesi. E per quanto riguarda “cultura africana” non è mai esistita in quanto essa è un insieme infinito di culture diverse. L’Africa è enorme, e sia chiaro che stiamo parlando della letteratura di cinquantaquattro nazioni e di più di tremila lingue e altrettanti dialetti. Il termine "africano" si riferisce agli africani, che possono appartenere a diversi gruppi etnici (per es. i Mursi in Etiopia; i Samburu in Masai Mara (Kenya); gli Ashanti in Ghana; i Zulu in Sudafrica; i Boscimani in Botswana ecc.)…), e la “letteratura” sta per le opere d’arte create da questa diversità.
2) L'Africa francofona aveva riviste come Présence Africaine, Peuples noirs, peuples africains, L'Afrique littéraire et artistique; l'Africa anglofona aveva una gamma più ampia di prime riviste: Black Orpheus, The Conch, The Horn, The Muse, Drum, Okike, Transition, Ba Shiru e African Literature Today. Sebbene la maggior parte di queste riviste non pubblichi più, Notre Librairie e Research in African Literatures rimangono le più importanti.
3) La letteratura in lingue africane è essenziale – secondo questo gruppo - perché serve come mezzo per mantenere vive e vegete le parole e i suoni delle lingue. È tragico sapere quante lingue siano andate perdute nel tempo, soprattutto se si considera quanto il linguaggio sia strettamente legato alla comprensione di concetti come tempo, spazio e cultura.